Gli acquedotti romani rappresentano nella storia un esempio di architettura idraulica di valore, così come uno dei simboli della grandezza culturale dell'Impero.
Si tratta di opere architettoniche e idrauliche che furono descritte da storici, letterati e visitatori della città con ammirazione e stupore. Nel dettaglio, le principali testimonianze sull’architettura degli acquedotti romani giungono dal De Architectura di Vitruvio mentre il saggio del curatore Sesto Giulio Frontino illustra come venivano amministrati, le loro caratteristiche e il loro percorso, informazioni che sono state utili per ricostruire la storia di queste opere pubbliche di immenso valore culturale e sociale.
È grazie a questi testi, infatti, se oggi sappiamo che, per garantire l’accesso ad acqua potabile di qualità, venivano effettuati costantemente rigidi controlli: infatti, i Romani si occupavano di monitorare i parametri di qualità e purezza dell’acqua, dalla sorgente fino ai punti di uscita.
Un approccio che nel corso dei secoli si è modificato ed evoluto, ma che rimane ancora oggi alla base dei processi eseguiti per assicurare a tutti noi acqua potabile.
Breve storia degli acquedotti romani
Gli acquedotti romani nacquero per soddisfare il bisogno di acqua di tutti gli abitanti di Roma e al tempo stesso garantirne la qualità fino al punto di erogazione.
Per secoli, infatti, le acque del Tevere, assieme a quella piovana, avevano rappresentato a Roma la principale fonte di approvvigionamento per i bisogni dell’uomo, in primis alimentari e igienici.
Con il passare del tempo, tuttavia, emerse il grande limite di queste fonti: l’inquinamento, ai tempi soprattutto organico, che favoriva intossicazioni ed epidemie che decimarono la popolazione.
L’esigenza di trovare acqua di qualità portò i governatori di allora a guardare verso le colline, soprattutto quelle a est, in cui furono identificate nei secoli diverse sorgenti naturali o fluviali che corrispondevano ai parametri di qualità richiesti allora per assicurare alla popolazione acqua potabile.
Le prime sorgenti furono intercettate a 16 Km a est di Roma, lungo la via Collatina, e per secoli alimentarono l’Aqua Appia, il primo acquedotto romano, la cui costruzione risale al 312 a.C. Nei successivi 500 ne furono costruiti altri 10, che avevano la capacità di portare a Roma ogni giorno 1 miliardo di litri di acqua corrente.
Oggi solo un acquedotto è ancora in funzione, l’Aqua Virgo, risalente al 12 d.C., mentre tutti gli altri 10 vennero distrutti nei secoli. Rimangono comunque numerosi resti di varie dimensioni sparsi per la città, che hanno permesso di ricostruire, insieme agli scritti di Vitruvio e Frontino, la mappa della distribuzione dell’acqua a Roma fino ai tempi dell’Impero.
Tra questi è possibile ricordare l’Aqua Tepula, così chiamato perché scorreva acqua tiepida con una temperatura sempre intorno ai 16-17 gradi, l’Aqua Claudia, costruito dall’Imperatore Claudio e ricordato come uno degli acquedotti più monumentali assieme all’Anio Novus, l’opera più imponente dell'architettura idraulica romana, con i suoi 87 km di lunghezza – di cui ben 14 su arcate – e una portata di 200.000 metri cubi di acqua al giorno.
I Romani fecero costruire i loro acquedotti anche in diverse colonie del loro vasto Impero. Ne costituiscono degli esempi l’acquedotto di Catania e l’acquedotto del Triglio, che serviva Taranto, ma ci sono evidenze anche oltre i confini italiani.
Acquedotti romani e società
Nell'antica Roma l'acqua aveva un importante aspetto “sociale” e politico, tanto che la costruzione di acquedotti diventò, per i Censori e gli Imperatori, parte di una strategia politica per assicurarsi il sostegno e il favore di plebei, patrizi e, più in generale, di ampie fasce di popolazione.
Inizialmente, l’acqua era offerta come servizio pubblico accessibile a tutti nei vari sbocchi dell’acquedotto, i castellum, chiamati così proprio perché la loro struttura ricordava un castello.
Nei secoli, oltre ai castellum, iniziarono a essere presenti degli sbocchi privati nelle Domus dei patrizi o dei senatori, soggetti a tributi, e anche alle terme: per esempio, uno sbocco dell’Anio Vetus alimentava le terme di Caracalla. Vennero sfruttati anche per scopi ludici, come nel caso dell’Aqua Asletina, che serviva anche per allagare la Naumachia, il circo a forma di ellisse in cui venivano svolte le famose battaglie navali romane.
In particolare, secondo Frontino l’acqua di Roma nei secoli venne distribuita fra tre destinatari:
- Il 44% a usus publicus;
- Il 38% ai privati;
- Il 17% nomine Caesaris (per l’Imperatore).
L’accesso all’acqua era controllato dai curator acquae, dei veri e propri vigilanti dell’acqua che ne evitavano gli sprechi, controllavano gli sbocchi privati abusivi e infliggevano pene ai trasgressori.
Tuttavia, quando iniziò il declino dell’Impero, gli acquedotti furono tra le prime opere a essere demolite e il Tevere ritornò a essere una delle principali fonti di approvvigionamento idrico della città.
Alcuni studiosi avrebbero associato la riduzione della popolazione di Roma nel Medioevo proprio alla distruzione degli acquedotti. Tale teoria è però controversa, dato che altri sostengono che comunque la distribuzione dell’acqua durante l’Impero romano favoriva solo i nobili, mentre al popolo venivano destinate quantità esigue, spesso di origine piovana.

Acquedotto romano: come funziona?
Gli acquedotti romani dalla sorgente agli sbocchi sfruttavano un principio molto semplice per far arrivare alla città di Roma l’acqua di cui aveva bisogno, la gravità. Ecco perché le sorgenti venivano scelte nelle colline, per poter sfruttare la forza gravità naturale data dalla pendenza.
Nello specifico, i canali o specus che portavano acqua all’acquedotto erano divisi in tratti in continuità: ogni tratto era posto a un’altezza leggermente superiore a quello successivo e inferiore a quello precedente. In tal modo, si manteneva sempre una certa inclinazione: la pendenza degli acquedotti romani, in particolare, si aggirava intorno al 2%.
Inoltre, inclinazione e sezione del tracciato erano determinate in modo scrupoloso per evitare che l'acqua durante il tragitto acquisisse eccessiva velocità ed erodesse le superfici di scorrimento.
Per calcolare la pendenza, venivano utilizzati principalmente 3 strumenti:
- La livella ad acqua, simile alla moderna bolla utilizzata ancora oggi;
- Il chorobates, una sorta di panca con fili a piombo sui lati, con una livella ad acqua al centro che permetteva di misurare la pendenza del terreno e verificare la direzione del flusso basandosi su tacche graduate;
- Il dioptra, una livella più sofisticata che, appoggiata a terra, permetteva di regolare per angolatura e rotazione con un mirino l’inclinazione del tratto di acquedotto. Ricorda il moderno teodolite, uno strumento ottico a cannocchiale per i rilievi topografici e geodetici.
Una volta determinata l’inclinazione si procedeva alla costruzione dell’acquedotto. Prima di tutto, l’acqua dalla sorgente veniva fatta convergere in una o più piscinae limariae, ovvero delle vasche di sedimentazione dove il flusso era rallentato per consentire a fango, terra e altre particelle di depositarsi sul fondo.
Le piscine limariae erano collocate lungo tutto il percorso dell’acqua fino alla città per permettere di liberarla dai detriti. Dalla prima piscina limaria, l’acqua veniva poi incanalata negli specus, che erano dei canali scavati nel terreno o nella roccia che scorrevano sotterranei per convergere nei punti di raccolta fuori dalle mura della città.
Quando l’acqua trovava delle depressioni, una parete scoscesa o una gola, venivano costruiti:
- Un ponte o un viadotto per oltrepassare il salto, mantenendo però il canale sotterraneo, ovvero scavato al suo interno;
- Un sifone invertito: in questo caso si sfruttava la forza di gravità generata dalla cascata d’acqua per farla risalire sul lato opposto. In generale, poco prima del salto si costruiva una cisterna di raccolta da cui si faceva scendere l’acqua per gravità. Spesso per ridurre l’altezza massima del salto e diminuire la pressione necessaria alla risalita dall’altro lato veniva costruito un piccolo viadotto.
Quando invece il tragitto era pianeggiante, l'opera proseguiva con le famose arcate, con un’altezza anche di 30 m per mantenere la pendenza per diversi chilometri, fino ai punti di raccolta in prossimità della città.
Da qui, le acque venivano convogliate nei sistemi di tubature che arrivavano fino ai castellum, alle case private, alla Domus imperiale, alle terme o ad altri punti di sbocco, come quelli industriali e ludici. A seconda dell’utilizzo, l’acqua era di qualità diversa, infatti quella da bere era migliore di quella a uso industriale o ludico.
Le sorgenti dei principali acquedotti romani erano quasi tutte poste a est, nelle colline in prossimità di Roma, fino a circa 70 Km. Oltre che per la pendenza, la scelta della sorgente doveva rispondere a determinate caratteristiche, ovvero doveva presentare acque:
- Limpide e pure;
- Inaccessibili a inquinanti;
- Prive di muschio e di canne.
Inoltre, venivano esaminate anche le condizioni generali e di salute degli animali che consumavano l’acqua della potenziale sorgente. In fase di analisi, inoltre, venivano monitorati parametri di qualità come purezza, sapore, temperatura, contenuto di sali minerali, capacità di corrosione, effervescenza, viscosità, presenza di corpi estranei e punto di ebollizione.
Le esaminazioni venivano eseguite in contenitori di bronzo di qualità. Lungo l’acquedotto erano inoltre presenti vari punti di controllo, in cui l’acqua veniva analizzata per accertarsi che non fosse stata in qualche modo contaminata.
Le tubature dell’acquedotto erano in terracotta o in piombo. La terracotta era considerata più salubre rispetto al piombo che poteva contaminare l’acqua. In realtà le contaminazioni da piombo sembrerebbero essere associate più agli utensili utilizzati in cucina, poiché sulle tubature si depositava spesso un film di calcare protettivo.
L’acqua di Roma infatti era ricca di calcare: non a caso, nei punti di controllo sparsi lungo gli acquedotti si monitoravano anche le incrostazioni per evitare si verificassero ostruzioni delle tubature.
Gli acquedotti romani ancora esistenti
Gli acquedotti edificati dagli antichi romani sono dei veri e propri capolavori di ingegneria idraulica che rimasero un unicum nel panorama delle opere di approvvigionamento idrico per oltre 1000 anni dopo la caduta dell'Impero.
Non a caso, ancora oggi, percorrendo le vie della Capitale e di alcune ex colonie romane, è possibile scorgere i preziosi resti di queste opere così preziose a livello storico e culturale e all'avanguardia dal punto di vista architettonico e strutturale.
L'Aqua Virgo, che come visto è l'unico acquedotto ancora funzionante, oggi alimenta alcune delle opere più importanti di Roma, tra le quali la Barcaccia di Piazza di Spagna e la Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona.
Oltre agli acquedotti romani in Italia, è possibile scorgere strutture ben conservate che testimoniano il passaggio di questa grandiosa civiltà nel resto del mondo a quei tempi conosciuto.
È il caso della Francia, dov’è possibile ammirare il Ponte del Gard, della Spagna, che ospita l’acquedotto di Segovia, ma anche della Palestina, dove sono attualmente visibili le mura dell'Acquedotto di Caesarea, e della Turchia, dove i tracciati ancora esistenti dell'acquedotto di Valente rappresentano i resti di quello che può essere considerato il più lungo acquedotto romano edificato oltre i confini italiani.

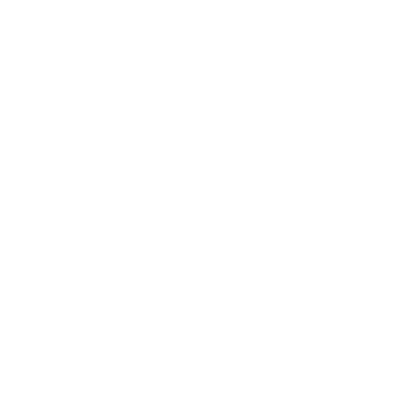
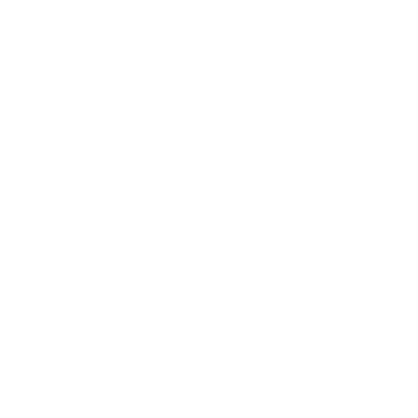
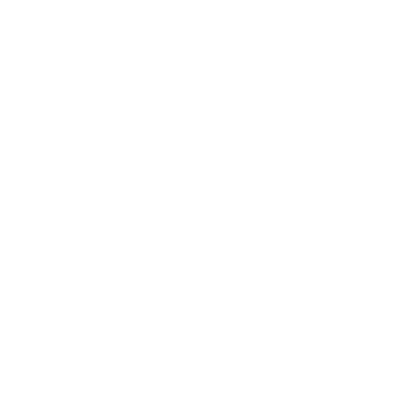

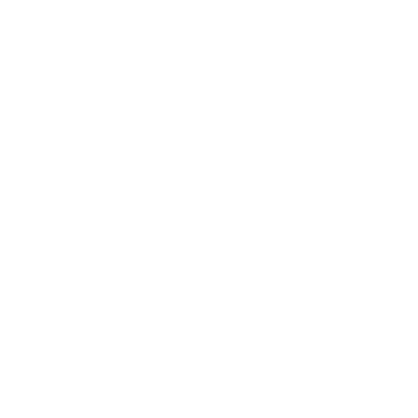
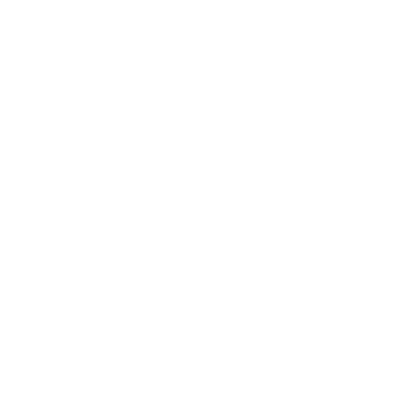









 Salute
Salute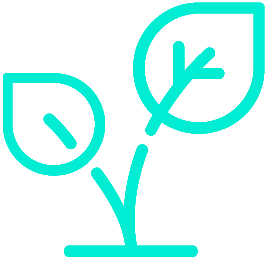 Ambiente
Ambiente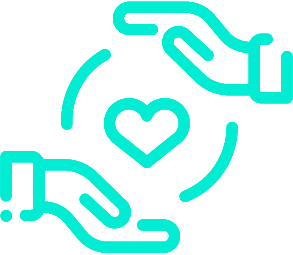 Come Fare
Come Fare Acqua & Scienza
Acqua & Scienza